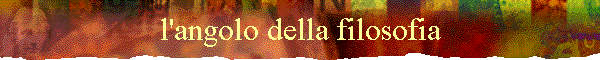|

Karl Marx
(1818 - 1883)
|
Liberiamo
Marx dai silenzi!
di Federico Guastella
Leggendo il titolo del libro di Diego Fusaro
"Bentornato Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario" (Milano,
Bompiani 2009), almeno una domanda è inevitabile che sorga: quale senso dare
alla riproposizione di Marx, ove si considerino le ideologie e le politiche
nefaste che hanno distinto la storia del Novecento? In altri termini,
nell’attuale contesto societario, per moltissimi aspetti diverso da quello
dell’Ottocento, cosa ancora può dirci Marx? E’ in fondo questo il medesimo
interrogativo del nostro giovane studioso al quale egli così risponde alla
fine del suo accurato itinerario di ricerca: Marx può ancora dare voce
alla sensazione diffusissima che il nostro mondo (sempre più presentato come
intrascendibile, in una inquietante desertificazione dell’avvenire), dopo
tutto, qualcosa continua a mancare. Come è stato scritto, “quelli di
Marx restano gli strumenti più acuti per criticare la società esistente e le
sue contraddizioni: fin tanto che ci saranno sfruttamento e schiavitù, lo
spettro di Marx continuerà ad agitarsi per il mondo (p. 309). Fusaro,
servendosi del romanzo di Juan Goytisolo Karl Marx show, facilita
così al lettore il compito di decifrare le storture e le forme precarie
della società in cui oggi si vive: quello di “immaginare un Marx redivivo
che assiste impotente alle disavventure del presente – dallo sbarco di
clandestini sulle coste pugliesi al lavoro schiavile dei bambini – vedendo
il suo “sogno di una cosa” mandato in frantumi dalla storia e dalle sue
“dure repliche (p.19)”. Le condizioni di alienazione che l’avevano
ossessionato permangono, e forse se ne sta perdendo la piena consapevolezza:
“il capitale si fa sempre più invisibile e impalpabile anche nella vita di
ciascun individuo”. |
|
Certamente il capitalismo non è stato soltanto un
male; ha segnato, anzi, un reale progresso rispetto allo stato feudale,
universalizzando la produzione e il mercato. In questo senso – commenta il
nostro studioso – ha posto le basi per un’effettiva civilizzazione
dell’umanità, creando possibilità di sviluppi ulteriori (p.289). A Fusaro,
comunque, non passano inosservate né le contraddizioni in atto del sistema
né i tanti problemi nel quadro delle società comunisticamente strutturate.
Anche il fallimento delle profezie di Marx è preso da lui in esame, ma egli
puntualizza che restano valide e attualissime le sue denunce radicali del
“sistema”.
Ripercorrendo ora il corpo sostanzioso della sua
imponente ricerca, possiamo dire che il discorso sul feticismo delle merci
(pp. 262-277) è senza dubbio uno degli assi portanti dell’attualità marxiana
in cui si colloca la contrapposizione delle classi sociali. Interessante
appare anche la definizione data da Fusaro al concetto di “classe”, in
considerazione che il pensatore di Treviri non tenta neanche una volta di
definirlo. Ricavandola dagli scritti marxiani, egli così la espone: “…, un
gruppo di individui che sono portatori di interessi socio-economici comuni e
che sono potenzialmente in grado di acquistare coscienza di sé quali membri
di una classe”. Una classe, dunque, contrapposta all’altra è la molla del
movimento storico, assunto nella concezione “materialistica della storia”
che consente di descrivere le leggi dell’economia: quelle leggi specifiche,
che oltre a determinare in un certo senso la volontà, la coscienza, le
intenzioni degli uomini, regolano la nascita, a partire dall’accumulazione
primitiva (dalla differenza sessuale alla società schiavistica prima e a
quella feudale dopo), l’esistenza, lo sviluppo e l’estinzione di un dato
organismo sociale, sostituito poi da un altro di livello superiore
(pp.107-153). A questo punto s’inquadra l’analisi particolareggiata sulla
teoria del valore (pp. 227-261) che pone in rilievo come il plusvalore
(“tempo di lavoro non pagato”) rende possibile la valorizzazione del
“capitale per il capitalista”. |

Diego Fusaro |
|
Marx, partendo dalle sue analisi economicistiche
nell’ambito della “rottura epistemologica” attinente al rovesciamento della
dialettica hegeliana (in Hegel il pensiero è il demiurgo del reale; per il
pensatore di Treviri il cominciamento è dato dall’elemento materiale in cui
si realizza la sintesi di teoria e prassi), non giunge poi alla
configurazione di caratteri ben precisi relativi alla società comunista.
Fusaro scrive che egli si limita, evitando di cadere nell’idea di un
livellamento come conseguenza di una malintesa distribuzione dei beni, a tre
affermazioni facenti leva, in sintesi, sul controllo della produzione, sullo
sviluppo delle individualità e dell’uomo onnilaterale, nonché
sull’estinzione dello Stato. Il suo commento, che scaturisce da una puntuale
documentazione, è abbastanza chiaro: “Con il comunismo lo Stato verrebbe
“tolto” in quanto strumento di oppressione di classe e “realizzato in quanto
strumento finalizzato alla realizzazione di scopi effettivamente
universali”.
Dunque: un pensiero, incompiuto e aperto, quello di
Marx. Chi ha pensato, o chi pensa, di dedurne una società già confezionata
non l’ha capito. Mi sembra questo il punto fondamentale della rilettura
delle opere di Marx fatta da Fusaro. Lettura autentica, la sua, liberata da
tutti i diversi silenzi e dal disprezzo profondo degli umani diritti che si
è attuato, utilizzandone le idee nel peggiore dei modi possibili. Lettura,
altresì, ancorata a visione della storia in chiave teleologica,
futurocentrica, pervasa di speranza messianica, tipica del “regno della
libertà”. In tale prospettiva (non falsificabile secondo la diagnosi di
Popper, in quanto irriducibile a teoria scientifica), rispetto alla visione
di Althusser, “problematica e aporetica”, a Fusaro appare più aderente alla
realtà storica il pensiero di Ernst Block. Per il filosofo di Tubinga, la
vera anima del pensiero di Marx, dalla gioventù alla maturità, è infatti la
speranza, “mediata da ciò che è realmente possibile” e intesa come
proiezione nell’ulteriorità, come aspetto essenziale del “non ancora”. Per
il filosofo di Tubinga – scrive Fusaro – essa sta in stretto rapporto “tra
lo spirito dell’utopia sociale rivoluzionaria cristiana e il pensiero
messianico - utopico di Marx (p.292), in quanto l’uomo, potremmo dire, è una
realtà molto complessa di cui la religione non è alienazione.
In sostanza, vuole dire Fusaro che Marx va riletto
e compreso allo scopo di rifluidificarlo senza il marxismo. Ciò è
importantissimo, anche se la rivisitazione che se ne deve fare sembra
ostacolata da molteplici fattori. Il determinismo “crisi” – crollo” del
capitalismo, rivelandosi utopistico, non si è realizzato e lo stesso nome di
Marx è rimasto collegato con le pesanti e drammatiche eredità delle società
comuniste. Il suo spettro inoltre viene falsamente evocato per impaurire,
mentre non mancano posizioni di retroguardia tali da rallentare la
costruzione di percorsi unitari. E si ha pure l’impressione di inibizioni
culturali per un serio approfondimento come se si volessero occultare le
colpe storiche. Sul piano effettuale la transizione, è noto, è avvenuta “dal
capitalismo ad un altro capitalismo” con l’esito di staccare l’economia
finanziaria da quella reale, mentre la stessa classe operaia si è rivelata
“uno dei gruppi sociali più facilmente integrabili tramite il consumismo e
il feticismo delle merci (p. 312)”.
Nell’ambito di questo processo di destrutturazione,
c’è ancora spazio di operatività per quell’idea antropologica che punta al
“soggetto” al fine di liberarlo da ogni sorta di alienazione economica ed
interiore? La rigorosa ricostruzione di Fusaro, fatta in autonomia, con
profonda attenzione all’ermeneutica e senza lenti riduttive, a questo punto
termina con l’ultimo capitolo intitolato “Le avventure del materialismo
storico: Marx nel Novecento”.
L’indagine culturale, potremmo dire, cede il passo
alla politica, auspicando che possa farsi centro di elaborazione progettuale
con strategie di alleanze aperte.
Federico Guastella
Maggio 2010
|
Home Page
|